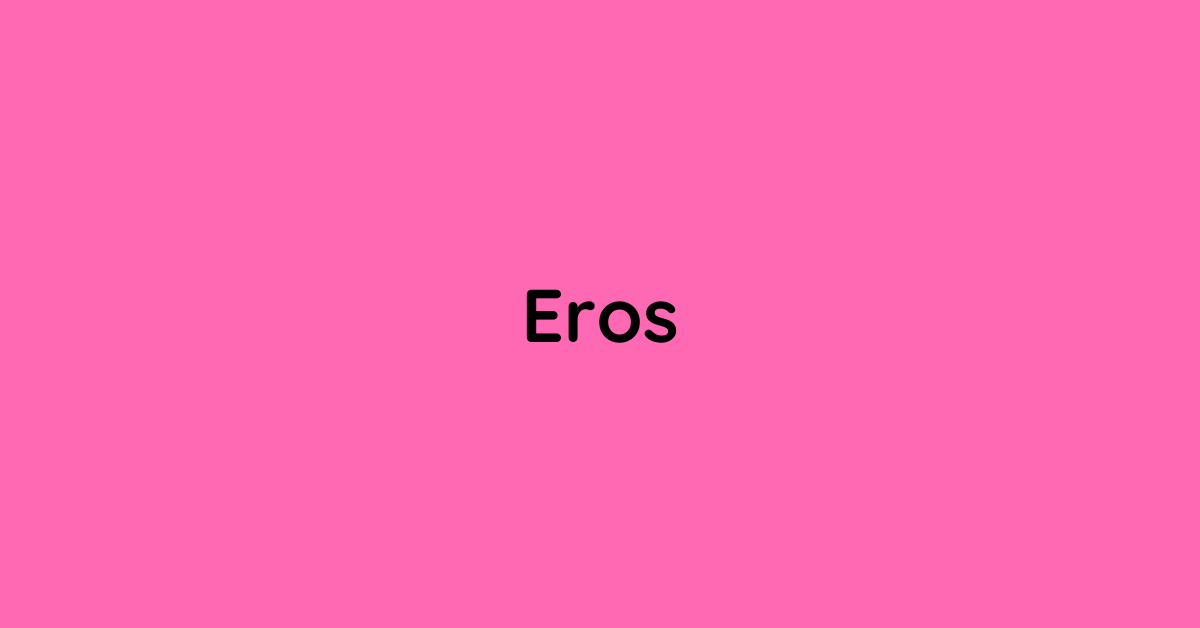
I contenuti dell'articolo:
Eros
Titolo originale: Eros
Anno: 2004
Nazione: Italia, Francia, Hong Kong, Regno Unito, Stati Uniti d’America
Genere: Drammatico, Sentimentale
Casa di produzione: Fandango, StudioCanal, Block 2 Pictures, Jet Tone Films, Section Eight
Distribuzione italiana: Fandango
Durata: 104 minuti
Regia: Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh, Wong Kar-wai
Sceneggiatura: Tonino Guerra, Steven Soderbergh, Wong Kar-wai
Fotografia: Christopher Doyle, Harris Savides, Marco Pontecorvo
Montaggio: William Chang, Sarah Flack, Sandro Petraglia
Musiche: Elliott Smith, Claudio Gizzi, Ryuichi Sakamoto
Attori: Robert Downey Jr., Alan Arkin, Gong Li, Christopher Buchholz, Luisa Ranieri, Chang Chen
Trailer di “Eros”
Informazioni sul film e dove vederlo in streaming
Eros è un film collettivo del 2004 nato dalla collaborazione di tre registi: Wong Kar-wai, Steven Soderbergh e Michelangelo Antonioni, ognuno dei quali dirige una delle storie che compongono l’opera, rispettivamente: “La mano”, “Equilibrium” e “Il filo pericoloso delle cose”.
Presentato alla sezione fuori concorso alla 61ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nel 2004, la proiezione attirò grande attenzione, soprattutto per il ritorno sullo schermo di Michelangelo Antonioni, all’epoca 91enne. Il suo episodio “Il filo pericoloso delle cose” è inoltre l’ultima opera cinematografica prima della sua morte avvenuta nel 2007.
Trama di “Eros”
Il primo episodio, “La mano” narra la storia di Zhao, un giovane sarto che sviluppa una vera e propria ossessione per una ricca cortigiana che segnerà la sua vita professionale e personale. Il secondo, “Equilibrium”, tratta invece il dialogo tra uno psicoanalista e un paziente disturbato da sogni ricorrenti su una donna.
Il terzo, “Il filo pericoloso delle cose”, segue la fine di una relazione tra un uomo e una donna e l’incontro con una figura femminile enigmatica.
Recensione di “Eros”
Il tema principale dell’intera pellicola è uno: il desiderio. Pulsione sessuale primordiale dell’uomo, capace di spingerlo verso la realizzazione personale oppure verso l’ossessione. “Eros” è un trittico ambizioso che attraversa culture, decenni e stili, cercando di esplorare l’erotismo attraverso tre racconti autonomi.
Questo concetto trova la sua forma più intensa nel primo episodio: “The Hand”.
Il giovane sarto Zhao, ancora innocente e inesperto nei confronti della propria professione e della vita, diventa ossessionato da Miss Hua, tanto da attribuire a lei la nascita della propria carriera. Tutto nasce da un primo incontro, in cui avviene uno scambio sessuale inappropriato, che lo spettatore può percepire quasi come una forma di sopraffazione. Da questa doppia iniziazione, Zhang inizia a lavorare sempre più spesso per la donna, osservandola, toccandola attraverso i tessuti, ma senza mai davvero possederla. L’unico contatto fisico, carico di tensione erotica e significato, è attraverso la mano.
Quella mano sostituisce il corpo intero, come se contenesse in sé tutto l’atto sessuale, concentrato in un solo gesto. Diventa feticcio e memoria, attorno a cui ruota per anni il desiderio del giovane. È l’erotismo dell’incompiuto, della tensione inespressa, dove l’immaginazione colma ciò che lo schermo non mostra.
Poi il tempo passa, le vite cambiano, ma quella prima carezza proibita rimane impressa come una cicatrice emotiva.
Wong Kar-wai firma l’episodio migliore del trittico, con la sua consueta sensibilità per il non detto e la bellezza malinconica degli amori irrealizzati.
Segue Equilibrium, di Steven Soderbergh. Non all’altezza del primo capitolo, ma comunque godibile. Narra di una seduta di psicoterapia tra il Dott. Pearl e Mr. Penrose, un pubblicitario che lavora per una ditta produttrice di sveglie, in un setting da commedia teatrale. Ironia della sorte, l’uomo porta al terapeuta proprio un problema notturno: il sogno ricorrente di una donna che lo ossessiona da tempo, al punto da generargli grande frustrazione a ogni risveglio, a ogni trillo della sua sveglia. Dall’altra parte, in maniera altrettanto ironica, abbiamo un clinico anch’esso ossessionato, che spinge il paziente a sdraiarsi sull’iconico divanetto non per il bene della terapia, ma per poter spiare indisturbato una donna attraverso la finestra con il proprio binocolo.
Equilibrium prende di mira le nevrosi della psicoanalisi post-freudiana degli anni Cinquanta, un’epoca di repressione dei desideri in cui l’ansia sessuale veniva vissuta come patologia, e la sua cura delegata a terapeuti freddi, direttivi e impassibili.
Interessante è anche l’uso della fotografia di questo cortometraggio. Tutto ciò che avviene al di fuori della terapia è rappresentato a colori (sogni compresi), mentre le sedute passano al bianco e nero. Si crea così uno spazio mentale separato, in cui si può giocare con l’estetica del cinema anni ’50, mescolando affetto e ironia. Rispetto al primo episodio, qui il desiderio è espresso in maniera più leggera, ma anche più facilmente dimenticabile.
Chiude il trittico “Il filo pericoloso delle cose”, diretto da Michelangelo Antonioni. Questo è certamente l’episodio più erotico tra i tre, anche grazie alle numerose scene di nudo integrale delle attrici. Narra la relazione tra Christopher e Cloe, due amanti in crisi che trascorrono una vacanza sulla costa toscana, ma la loro relazione è ormai logora, fatta di incomprensioni e freddezza. Dopo l’ennesimo litigio, la donna se ne va e l’uomo incontra Linda, una figura tanto sensuale quanto infantile, che vive isolata in una torre. L’incontro, scritto in maniera surreale, si carica immediatamente di erotismo ma non conduce a nulla di significativo. I dialoghi risultano banali, le relazioni si costruiscono su conversazioni che oscillano tra l’inverosimile e il grottesco, facendo perdere forza alla narrazione e al messaggio centrale.
Il desiderio qui non è vissuto visceralmente come nel primo episodio, né idealizzato o sublimato come nel secondo. È vissuto attraverso i corpi nudi degli attori, in maniera sicuramente più carnale ma più povera di linguaggio. Le inquadrature sono belle ma statiche, i dialoghi criptici, i personaggi corpi vuoti che emettono suoni senza realmente comunicare. L’erotismo si perde in un’estetica che guarda senza toccare, mostra senza coinvolgere.
In conclusione
I formato antologico di Eros sarebbe potuto essere il suo vero punto di forza, consentendo di giocare con il concetto di desiderio/pulsione in stili e visioni differenti. Invece lo è solo in parte. Il problema è che solo il primo episodio riesce a evocare davvero la complessità del tema, prediligendo un approccio silenzioso, fatto di gesti minimi, sguardi, attese. Non veniamo guidati nella comprensione, siamo noi a dover intuire i personaggi attraverso il non detto.
Soderbergh, con il suo episodio, crea invece un clima ironico e divertente, ma nulla di più. Non riesce a raggiungere l’impatto registico dimostrato in opere successive come il brillante Presence o l’intrigante Black Bag – Doppio gioco. Va invece riconosciuta la buona performance di Robert Downey Jr. nel ruolo del paziente. L’attore con una recitazione dinamica, fatta di movimenti nervosi e un linguaggio spedito, riesce a restituire con efficacia la condizione di stress e ossessione vissuta da Mr. Penrose.
A chiudere la pellicola è invece Antonioni, che dirige un segmento dissonante e confuso rispetto al resto dell’opera.
E così, in quasi tutto il film, quell’eros che avrebbe dovuto vibrare sotto la pelle resta invece intrappolato nella mente: sterile, freddo, incapace di farci provare qualcosa di reale.
Note positive
- Poetica del primo episodio: “La mano”
- Eterogeneità dell’opera grazie al formato antologico
- Uso consapevole della fotografia
Note negative
- Dislivello qualitativo tra gli episodi
- Eros come concetto poco vibrante nell’intera opera
- Dialoghi e caratterizzazione dei personaggi nell’episodio diretto da Antonioni
L’occhio del cineasta è un progetto libero e indipendente: nessuno ci impone cosa scrivere o come farlo, ma sono i singoli recensori a scegliere cosa e come trattarlo. Crediamo in una critica cinematografica sincera, appassionata e approfondita, lontana da logiche commerciali. Se apprezzi il nostro modo di raccontare il Cinema, aiutaci a far crescere questo spazio: con una piccola donazione mensile od occasionale, in questo modo puoi entrare a far parte della nostra comunità di sostenitori e contribuire concretamente alla qualità dei contenuti che trovi sul sito e sui nostri canali. Sostienici e diventa anche tu parte de L’occhio del cineasta!
| Regia |
|
| Fotografia |
|
| Sceneggiatura |
|
| Colonna sonora e sonoro |
|
| Interpretazione |
|
| Emozione |
|
|
SUMMARY
|
3.3
|


