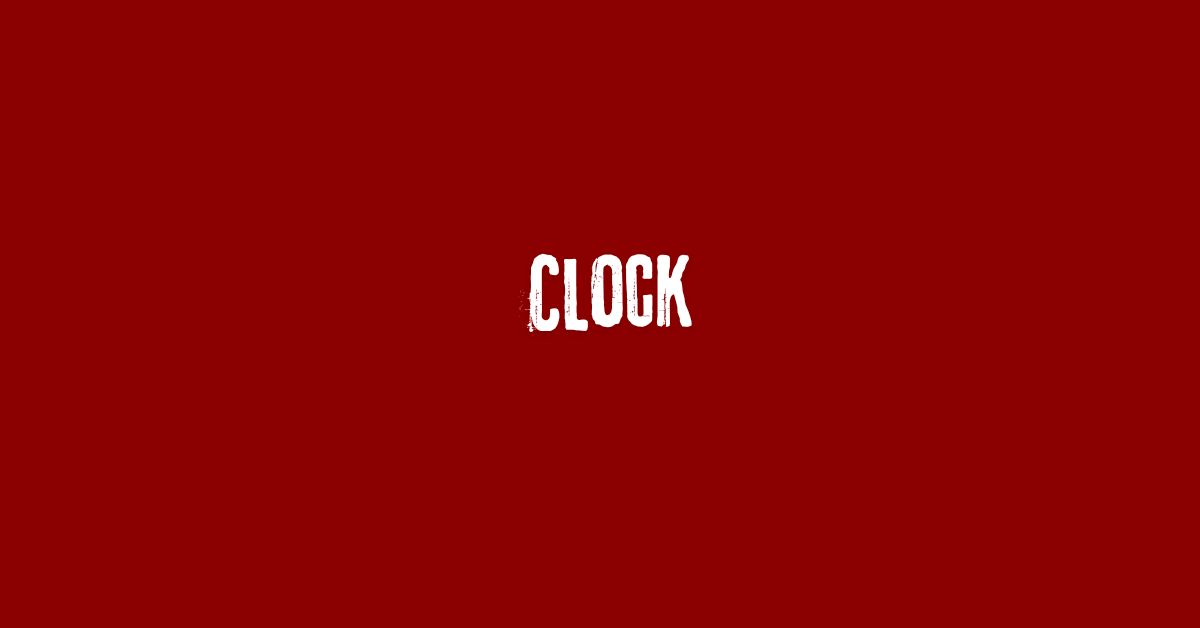I contenuti dell'articolo:
Black Mirror: Hotel Reverie
Titolo originale: Black Mirror: Hotel Reverie
Anno: 2025
Nazione: Regno Unito
Genere: Fantascienza, Drammatico
Casa di produzione: Zeppotron, Channel 4 Television Corporation, Babieka, Banijay Entertainment, Broke and Bones, Gran Babieka, House of Tomorrow
Distribuzione italiana: Netflix
Durata: 76 minuti
Regia: Haolu Wang
Sceneggiatura: Charlie Brooker
Fotografia: Aaron Morton
Montaggio: Chris Hunter
Musiche: Leigh Ashworth
Attori: Issa Rae (Brandy), Emma Corrin (Dorothy), Awkwafina (Kimmy), Harriet Walter (Judith Keyworth)
Trailer di “Black Mirror: Hotel Reverie”
Informazioni sul film e dove vederlo in streaming
Black Mirror: Hotel Reverie è il terzo episodio della settima stagione della serie Black Mirror, e con una durata di 1 ora e 16 minuti, risulta essere il secondo episodio più lungo della serie dopo USS Callister: Verso l’infinito di Toby Haynes (1h e 28 minuti).
Scritto dal creatore della serie Charlie Brooker, l’episodio segna il debutto nel lungometraggio della regista cinese Haolu Wang, trasferitasi a Londra. Wang ha già diretto diversi cortometraggi, tra cui Emma (2016) e The Pregnant Ground (2019), oltre a firmare la regia dell’episodio speciale di Doctor Who Legend of the Sea Devils (2022) e di quattro episodi della miniserie Netflix Bodies.
Il cast vede protagonista Issa Rae (The Lovebirds, 2020; Vengeance, 2022) nel ruolo di Brandy, affiancata da Emma Corrin nel ruolo di Dorothy, interprete apprezzata per la sua Lady Diana nella quarta stagione di The Crown, ruolo che le è valso un Golden Globe. A completare il trio principale troviamo Awkwafina, attrice e comica americana di origini sudcoreane, candidata come miglior attrice ai Golden Globe 2020 per The Farewell.
Hotel Reverie, come tutta la settima stagione di Black Mirror – serie che esplora il mondo della fantascienza attraverso episodi autoconclusivi, ciascuno assimilabile a un mediometraggio o lungometraggio – debutta su Netflix il 10 aprile 2025. L’attesa è stata lunga: la sesta stagione, composta da cinque episodi, era stata rilasciata il 15 giugno 2023, ma aveva ricevuto un’accoglienza piuttosto tiepida da parte di pubblico e critica.
Trama di “Black Mirror: Hotel Reverie”
La Keyworth Pictures, storica casa di produzione celebre per aver realizzato pellicole iconiche soprattutto tra gli anni ’40 e ’50, sta attraversando un periodo particolarmente difficile dal punto di vista economico. Ormai incapace di finanziare nuovi progetti, la compagnia si trova nell’impossibilità di lavorare con le grandi star internazionali, quelle in grado di attirare il pubblico nelle sale cinematografiche. Schiacciata dai debiti e sull’orlo del fallimento, l’anziana direttrice accetta un’offerta insolita da parte di Kimmy, una giovane imprenditrice ambiziosa. Kimmy propone di realizzare il remake di Hotel Reverse, uno dei più grandi successi del catalogo Keyworth, rivisitandolo però in chiave contemporanea e con una produzione ridotta all’osso. Il progetto prevede l’impiego di una sola star del cinema attuale e la durata esatta di 96 minuti per la realizzazione del film, utilizzando la rivoluzionaria tecnologia Readream – che va oltre le logiche dell’intelligenza artificiale – con cui è possibile realizzare l’intero film con risorse minime, aprendo le porte a una modalità di produzione completamente nuova, tanto affascinante quanto inquietante.
Il problema, però, è che nessuna delle grandi star maschili accetta di interpretare il ruolo del dottor Alex Palmer, protagonista assoluto del film. Un ruolo centrale, complesso, magnetico. Troppo rischioso per alcuni, troppo “fuori schema” per altri. L’unica a mostrarsi interessata – anzi, determinata a ottenerlo – è Brandy Friday, celebre attrice hollywoodiana in cerca di un’occasione che la allontani definitivamente dai ruoli secondari che l’hanno resa popolare, ma che l’hanno anche intrappolata in una gabbia di stereotipi. Per la prima volta, Brandy vuole essere la protagonista, non la spalla. E vuole farlo in un ruolo maschile, sovvertendo ogni aspettativa. Mancando alternative, Kimmy e la direttrice della Keyworth Pictures decidono di affidarle la parte, pur consapevoli che si tratta di una scelta controversa. Ma Brandy è un nome di punta, in grado di attirare l’attenzione.
Nel giro di poche ore, l’attrice riceve un pacco dalla produzione: il copione completo, un DVD del film originale, e una chiavetta USB contenente tutte le informazioni sulla tecnologia Readream. Ma, nel momento in cui apre la scatola, la chiavetta cade a terra. Brandy non se ne accorge nemmeno. Arrivata sul set viene immediatamente fatta sdraiare su un lettino, dove le vengono applicati due sensori sulla testa e senza quasi senza accorgersene, viene proiettata all’interno del mondo del film Hotel Reverse.
È un mondo in bianco e nero. Statico, ovattato. Ma vivo. I personaggi credono di essere reali, e lo sembrano anche troppo. Fra tutti, spicca Clara Ryce, l’ereditiera tormentata, interpretata da una giovane Dorothy Chambers, diva del passato scomparsa nel 1962. Clara la guarda, la tocca, le parla. La riconosce. La storia sembra inizialmente procedere secondo il copione, ma ben presto qualcosa cambia, a causa di un errore di Brandy. Gli eventi cominciano a deviare. Le battute non sono più quelle del film originale e la narrazione si piega, si contorce, tanto che Brandy Friday si rende conto di non poter più distinguere la finzione dalla realtà, e che, forse, non è più semplicemente un’attrice in un ruolo… ma parte integrante di un film che sta riscrivendo se stesso.

Recensione di “Black Mirror: Hotel Reverie”
Qual è il futuro della settima arte? Quale impatto avranno le tecnologie, in particolare l’intelligenza artificiale e la robotica, nella creazione delle opere artistiche, dove l’elemento centrale dovrebbe essere l’individualità dell’essere umano? Quest’ultimo, infatti, è colui che, all’interno di uno scritto, di un disegno o di una performance attoriale, mette in gioco il proprio io, le proprie emozioni consce e inconsce.
In un mondo in cui l’intelligenza artificiale avanza a passi da gigante, riscrivendo la realtà e mettendo a rischio professioni artistiche, giornalistiche e legate al flusso d’informazioni, le normative globali sapranno mantenere al centro l’individualità dell’essere umano? Oppure, in un contesto dove l’economia sembra essere il motore primario, gli stati e le aziende – incluse quelle cinematografiche – si concentreranno esclusivamente sugli aspetti economici, relegando l’arte a un ruolo secondario? Sarà questo il futuro, dove l’arte verrà sacrificata a favore della possibilità di realizzare film a basso costo sfruttando le tecnologie emergenti, come l’AI?
Charlie Brooker, nello sceneggiare “Hotel Reverie”, si è chiaramente ispirato al contesto sociale contemporaneo, in una società in cui l’intelligenza artificiale, soprattutto dopo la diffusione di OpenAI, sta entrando con forza e prepotenza nell’uso quotidiano. Nel 2023, infatti, sceneggiatori e attori del cinema americano sono stati costretti a scioperare per mesi, nel tentativo di contrastare l’invasione dell’AI sui set cinematografici, dove il rischio concreto era – e resta – quello di essere estromessi dal processo creativo e privati del proprio lavoro artistico, dove l’artisticità viene scartata a favore di un mero uso tecnologico privo di autorialità e di umanità.
Alla luce di questo scenario, tra la decadenza del cinema statunitense e le crescenti difficoltà economiche legate alla produzione di un film nel XXI secolo – complici i bassi ricavi generati dall’ascesa delle piattaforme streaming – Brooker ci racconta la storia di una casa di produzione in crisi che pur di tornare alla ribalta e produrre un nuovo lungometraggio, decide di imboccare una scorciatoia: affidarsi a una tecnologia rivoluzionaria, capace di realizzare il remake di un cult cinematografico senza il rischio della bancarotta, senza l’impiego di troupe tecniche o attoriali e senza la necessità di ricorrere a location fisiche, ma sfruttando una sorta di AI.
Il creatore di Black Mirror, così, ci trascina in una realtà cinematografica virtuale per metterci in guardia sui pericoli dei nostri tempi, mostrando le possibili scorciatoie produttive che le case cinematografiche, supportate dalle giuste tecnologie, potrebbero intraprendere per ridurre i costi e aumentare il numero di produzioni annuali. Alla fine, sia per le major che per le piccole case di produzione, la domanda fondamentale è: ciò che interessa è la qualità o il guadagno? Se fosse possibile realizzare remake dei grandi film del passato, come Casablanca (da cui Hotel Reverie trae notevoli ispirazioni) o Via col Vento, senza l’uso di set, troupe o location, ma trascinando la coscienza di un attore odierno in carne e ossa all’interno di quella pellicola, nel mondo artificioso in bianco e nero e nel contesto narrativo del lungometraggio, facendolo recitare al fianco di icone del passato come Ingrid Bergman o Vivien Leigh, credete davvero che le grandi case di distribuzione e produzione cinematografica non coglierebbero questa opportunità? Alla fine, il nostro è un mondo che guarda all’economia e che è avvezzo, nel mondo del cinema, ad effettuare remake, tanto che il rifacimento dei grandi classici è una pratica ormai abbastanza abusata nel ventunesimo secolo.
Ovviamente, lo sceneggiatore dell’episodio filmico non si limita a un’analisi della crisi economica che affligge le case di produzione, ma approfondisce anche la pericolosità insita nell’impiego di questo strumento tecnologico: un dispositivo capace di mettere a rischio la vita stessa dell’attore, specialmente quando le linee narrative, a causa di errori nei tempi o nei dialoghi, prendono direzioni inattese e divergenti. È il caso di questa drammaturgia, dove l’incapacità di Brandy Friday di suonare il pianoforte genera un intoppo narrativo che devia completamente lo sviluppo del racconto, conducendolo lungo traiettorie inaspettate e potenzialmente pericolose, fino a riscrivere radicalmente le scene, gli eventi e i personaggi, in particolare quello della protagonista femminile, la triste ereditiera Clara Ryce.
Senza rivelare troppo, Clara, nel corso del film, a causa di un errore narrativo-tecnologico di grande rilievo, giunge a una presa di coscienza: comprende la propria vera identità, scoprendo di essere un artefatto, una creatura fittizia, una sorta di eco della coscienza della sua interprete originale, la star Dorothy, morta suicida molti anni prima nel 1962 (non è un caso che è il medesimo anno di morte di Marilyn Monroe). Questo riflesso dell’anima di Dorothy si insinua prepotentemente, in maniera evidente fin dalle prime scene, nella coscienza artificiale di Clara Ryce, alterandone comportamenti ed emozioni, fino a farle rivivere esperienze che non appartengono al personaggio di “Hotel Reverie”, bensì a quelli vissuti dalla vera Dorothy, della quale – attraverso una scena ben costruita, intensa ma non didascalica – ci viene restituito il dramma personale, immerso nel vissuto doloroso di una donna degli anni ’40, morta suicida a causa della sua immane tristezza.
Tuttavia, il film manca di un autentico sviluppo del personaggio di Clara: non assistiamo al suo crollo psicologico nel momento in cui realizza di non essere reale, ma solo un artificio. Si tratta di una scelta narrativa quantomeno discutibile, soprattutto se si considera la portata filosofica e metaforica di questa rivelazione, che avrebbe potuto rappresentare il culmine emotivo dell’intero racconto. Quando Clara esce dal mondo filmico e si ritrova in uno spazio “vuoto” – probabilmente una porzione di rete priva di coordinate, un limbo digitale – lo spettatore è naturalmente portato ad aspettarsi un momento di rottura: uno scontro tra la coscienza fittizia e l’identità assente, un abisso esistenziale in cui il personaggio, privato delle sue fondamenta, affronta il terrore del non essere.
Eppure tutto questo, sorprendentemente, non avviene. La scena, pur visivamente affascinante e concettualmente carica di significato, si sviluppa in modo eccessivamente asciutto, quasi neutro, priva di quell’urgenza drammatica che ci si aspetterebbe. Il vuoto che Clara esplora sembra più un espediente illustrativo che un’occasione per scardinare le certezze del personaggio. Manca la vertigine, manca l’angoscia ontologica. Lo spettatore resta in attesa di un collasso emotivo, di una crisi che metta a nudo l’identità fragile della protagonista, e invece si trova di fronte a una sequenza controllata, trattenuta, quasi meccanica. È un’occasione mancata, che depotenzia la portata emotiva del racconto e priva Clara della complessità che il suo arco narrativo avrebbe meritato.
E questo dispiace ancora di più se si considera l’eccezionale performance di Emma Corrin, che riesce comunque a infondere al personaggio una delicatezza malinconica e una sensibilità vibrante, suggerendo attraverso piccoli gesti e sguardi l’inquietudine di una coscienza presente e di emozione intense e vivide. che L’attrice riesce a far emergere quella sottile crepa che si insinua nell’identità artificiale di Clara, ma è il copione a non offrirle il terreno adatto per esplodere emotivamente. Un contrasto che si nota ancor più se confrontato con la prova impacciata e scolastica della collega che interpreta Brandy Friday, la cui presenza scenica risulta fiacca e poco incisiva. Così, paradossalmente, è proprio la storyline più interessante e promettente ad apparire soffocata da una regia e una scrittura che scelgono la sottrazione laddove sarebbe servita una piena immersione emotiva.
Effettivamente, se io scoprissi di essere finto, ne uscirei distrutto: perderei ogni riferimento, ogni legame con la realtà, ogni illusione di autonomia. E allora, perché Clara non sperimenta alcun crollo emotivo? Perché questa donna, posta di fronte alla rivelazione devastante della propria inconsistenza ontologica, non affronta una crisi d’identità che sia realmente tangibile, violenta, disperata?. La consapevolezza dell’artificio, del non essere, avrebbe dovuto detonare all’interno del personaggio, spalancando un abisso emotivo capace di trascinare con sé anche lo spettatore. E invece resta tutto in superficie, suggerito ma mai veramente esplorato, lasciando Clara intrappolata in una condizione di semi-consapevolezza priva di reale potenza emotiva.
Questa assenza di reazione emotiva – o quantomeno di un’elaborazione interiore che vada oltre lo sguardo perso nel vuoto – depotenzia il messaggio stesso del film, che sembra rinunciare a interrogarsi profondamente sulle implicazioni filosofiche dell’identità artificiale, limitandosi a evocare temi complessi senza il coraggio di affrontarli fino in fondo. Eppure, era proprio lì che la storia poteva toccare vette emotive altissime, portando in scena non solo la morte dell’autenticità, ma anche la nascita dolorosa di una nuova coscienza condannata alla finzione.
Al contrario, il dramma vissuto da Brandy Friday, pur in assenza di una caratterizzazione particolarmente stratificata e – come già evidenziato – di una performance davvero incisiva, riesce a colpire lo spettatore in modo più diretto, raccontandoci di un personaggio che perde la consapevolezza di ciò che è vero e ciò che invence è un artificio. Il suo dolore è più umano, più riconoscibile, forse perché radicato in conflitti interiori meno ambiziosi ma più concreti. Ed è proprio questa dimensione più terrena, meno astratta, a restituire quel senso di tristezza profonda e struggente che aveva reso indimenticabili le prime stagioni di Black Mirror: storie dal sapore amaro, dove la perdita, la solitudine e la malinconia si impongono come cuore pulsante della narrazione.
In conclusione
“Hotel Reverie” offre un ritratto intrigante di un futuro artistico minacciato dall’uso indiscriminato dell’AI, ma si perde nel mancato approfondimento emotivo dei suoi personaggi chiave. Sebbene la narrazione tocchi temi rilevanti, la superficialità di alcune scelte autoriali limita l’impatto complessivo. Nonostante ciò, Emma Corrin brilla nel suo ruolo, portando un’intensità autentica ed emotiva nella pellicola dal fare sentimentale.
Note positive
- Emma Corrin offre una performance emozionante
- La riflessione sulla tecnologia e sull’individualità è attuale e stimolante.
Note negative
- : Lo sviluppo emotivo dei personaggi è carente
- Clara Ryce non subisce il tracollo psicologico necessario per intensificare la narrazione