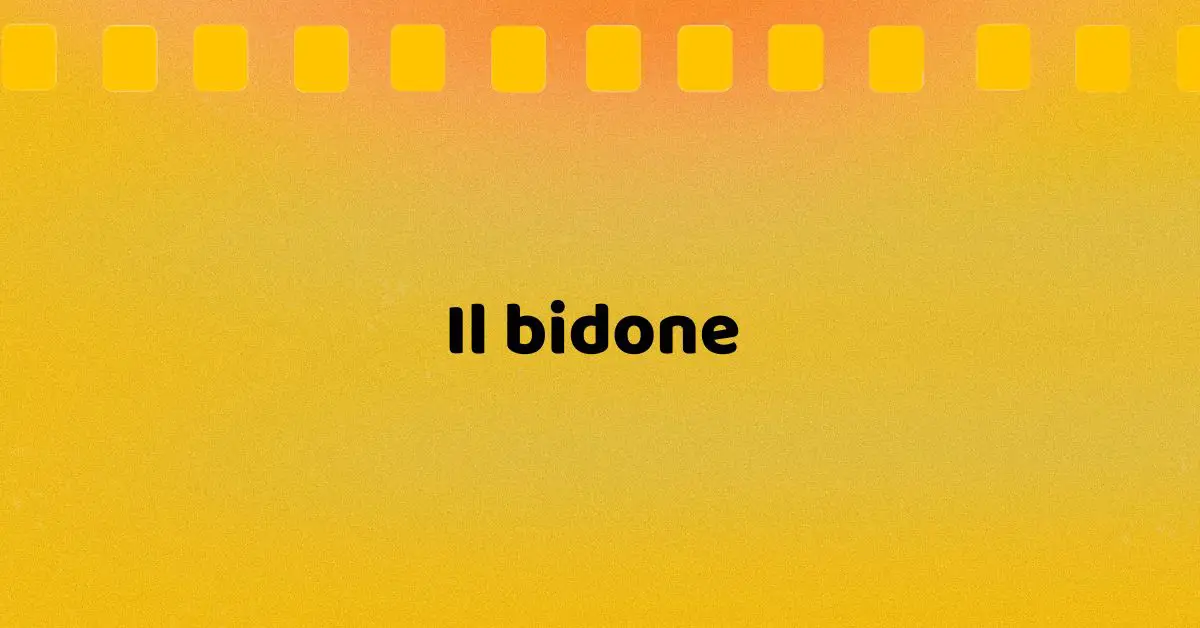I contenuti dell'articolo:
La scomparsa di Josef Mengele
Titolo originale: Das Verschwinden des Josef Mengele
Anno: 2025
Genere: Drammatico, Thriller Storico
Casa di produzione: CG Cinema, Hype Studios
Distribuzione italiana: Europictures
Durata: 136 minuti
Regia: Kirill Serebrennikov
Sceneggiatura: Kirill Serebrennikov
Fotografia: Vladislav Opelyants
Montaggio: Hansjörg Weissbrich
Musiche: Ilya Demutsky
Attori: August Diehl, Max Bretschneider, David Ruland, Friederike Becht, Mirco Kreibich, Dana Herfurth, Karoly Hajdyk, Falk Rockstroh, Annamaria Lang, Thilo Werner, Burghart Klaussner, Christoph Gawenda
Trailer di “La scomparsa di Josef Mengele”
Informazioni sul film e dove vederlo in streaming
Mi è stato proposto abbastanza tempo fa, la trasposizione del romanzo de La scomparsa di Josef Mengele di Oliver Guez, prima ancora che il romanzo fosse tradotto in russo, quindi l’ho scoperto inizialmente in inglese. Subito, c’è stato qualcosa che mi ha interessato nell’idea di adattarlo, anche se naturalmente il compito era arduo… Che fine fanno i criminali di guerra una volta finita la guerra? Esiste una giustizia divina? Queste persone vengono raggiunte dal loro passato? La questione del karma, del castigo, della giustizia… tutto questo mi ha sempre interessato. Inoltre, questo libro di Olivier Guez fornisce documentazione e stimola l’immaginazione: mi ha permesso di immaginare molte cose, per esempio riguardo all’incontro tra Josef Mengele e suo figlio, dato che non si sa nulla di ciò che si sono detti, non c’erano testimoni. Ho lavorato da solo alla sceneggiatura, poi l’ho presentata per rilettura a Olivier Guez che ha apportato alcune modifiche e l’ha validata. Per me era importante che approvasse questa sceneggiatura perché padroneggia molto bene l’argomento, ha indagato a lungo. Da parte mia, ho letto tutto ciò che è stato scritto su Josef Mengele, su Auschwitz e sulla vita dei nazisti dopo la guerra.
Cit. Kirill Serebrennikov, il regista
Dal regista russo Kirill Serebrennikov — autore da sempre critico nei confronti del governo Putin e già responsabile di opere come La febbre di Petrov (2018), Limonov: The Ballad (2024), suo primo film realizzato fuori dalla Russia, e La moglie di Tchaikovsky (2021) — prende forma nel 2025 il dramma storico La scomparsa di Josef Mengele, liberamente tratto dal romanzo La Disparition de Josef Mengele (2017) del giornalista francese Olivier Guez. Presentato il 20 maggio 2025 al Festival di Cannes nella sezione Première — festival particolarmente legato al cineasta, che vi ha portato tutte le sue opere — il film ricostruisce la lunga fuga del medico e criminale di guerra tedesco Josef Mengele.
Nato nel marzo 1911 a Günzburg e morto sotto falsa identità a Bertioga, in Brasile, il 7 febbraio 1979, Mengele trascorse decenni di latitanza dopo essere sfuggito al processo di Norimberga, trovando rifugio a partire dal 1949 in Sud America, soprattutto tra Brasile e Argentina. Conosciuto come “l’angelo della morte”, fu uno dei più feroci sostenitori dell’ideologia nazista e operò come medico nei campi di sterminio di Birkenau e Auschwitz, dove condusse esperimenti pseudoscientifici sui prigionieri ebrei, uccidendoli per dimostrare l’inesistente superiorità della razza ariana.
La pellicola si concentra sulle vicende del dopoguerra, seguendo la parabola discendente di un uomo che tenta disperatamente di cancellare le proprie tracce mentre il mondo, lentamente, inizia a ricostruire la memoria dei suoi crimini. Nei panni del protagonista troviamo August Diehl — il Dieter Hellstrom di Bastardi senza gloria e il Karl Marx de Il giovane Karl Marx – accanto a Maximilian Meyer-Bretschneider e Friederike Becht. Il film è stato distribuito nelle sale italiane da Europictures a partire dal 29 gennaio 2026.
Vuoi aggiunger il titolo alla tua collezione Home video?
Trama di “La scomparsa di Josef Mengele”
Alla fine della Seconda guerra mondiale, Josef Mengele — il medico di Auschwitz noto come “l’Angelo della Morte” — riesce a sottrarsi alla cattura e a dissolversi nell’anonimato. Nato a Günzburg, in Baviera, nel 1911, aveva costruito la propria carriera all’interno dell’apparato ideologico nazista: nel 1937 entra all’Istituto di biologia ereditaria e igiene razziale di Francoforte, l’anno successivo aderisce al partito nazista e alle SS, e nel 1943 diventa medico capo ad Auschwitz‑Birkenau, dove partecipa alle selezioni per le camere a gas e supervisiona esperimenti pseudoscientifici su esseri umani.
Con la caduta del Reich, Mengele evita i processi che travolgono molti suoi colleghi. Tra il 1945 e il 1949 vive nascosto in Baviera, lavorando come bracciante agricolo sotto falso nome, mentre nel 1949 riesce a imbarcarsi da Genova verso il Sud America, dando inizio a una lunga fuga che lo porterà a costruirsi una nuova identità in Argentina, dove vive fino al 1956. In quell’anno rientra brevemente in Germania sotto falsa identità, per poi tornare a Buenos Aires, dove nel 1958 si risposa con la fidanzata del fratello deceduto, circondato da nostalgici del Grossgermanisches Reich.
L’idillio argentino si interrompe bruscamente nel 1958, quando viene arrestato dalla polizia locale per alcune attività mediche sospette. Identificato come Mengele, riesce a corrompere un agente e a fuggire, sottraendosi ancora una volta alla giustizia. Nel 1962, ormai senza moglie e con una nuova identità, si trasferisce in Brasile, a Santa Lucia Fazenda, ospite di una famiglia di contadini ungheresi. È qui che apprende la notizia della cattura del suo amico Adolf Eichmann da parte del Mossad, evento che alimenta la sua paranoia e lo costringe a una vita sempre più isolata e claustrofobica.
Nel 1977, ormai vecchio, malato e solitario, riceve la visita del figlio Rolf nei pressi di San Paolo, uno dei rarissimi contatti con la sua vita precedente. Due anni dopo, nel 1979, muore annegato al largo di Bertioga, senza essere mai stato processato per i crimini commessi. Solo nel 1985, grazie a una perizia medica, la sua identità viene definitivamente confermata, chiudendo una delle fughe più lunghe e controverse del dopoguerra e lasciando aperta una ferita nella memoria collettiva: quella di un criminale che non ha mai affrontato la giustizia.
Recensione di “La scomparsa di Josef Mengele”
Non è mai semplice realizzare un lungometraggio tratto da una storia realmente accaduta, soprattutto quando riguarda una delle figure più mostruose dell’umanità come Josef Mengele. L’uomo che, durante il nazismo, non esitò a uccidere a sangue freddo e a compiere atti di crudeltà indicibile, arrivando a togliere la vita a più di un migliaio di ebrei e deportati nei campi di concentramento. Uomini, donne e bambini utilizzati come cavie da laboratorio, sottoposti a esperimenti pseudoscientifici — vere e proprie torture — soprattutto sui gemelli, per poi essere uccisi e dissezionati al servizio della follia razziale delle SS.
Mai pentito, mai scalfito da un briciolo di rimorso, profondamente legato all’ideologia nazista, Mengele ottenne presto il soprannome di “Angelo della Morte”, un appellativo, da lui profondamente odiato e ritenuto ingiusto, che restituisce con precisione la natura della sua malvagità e della sua deriva psicologica. È proprio su questa assenza totale di pentimento, su questo amore cieco e incondizionato per la Germania hitleriana e per il suo apparato ideologico, che si concentra il film di Kirill Serebrennikov. Il regista sceglie di non creare alcuna empatia tra spettatore e protagonista, mantenendo un distacco emotivo netto: una scelta coerente, ma che alla lunga priva la narrazione di una vera tensione drammaturgica, lasciando lo spettatore in una posizione di osservazione più che di coinvolgimento.
La pellicola tenta comunque di indagare la psicologia di questo uomo, raccontandone la frustrazione, la sofferenza e la prigionia interiore vissuta durante la latitanza. Josef Mengele, fervente sostenitore della Germania nazista e odiatore del comunismo sovietico e degli ebrei, si ritrova a vivere come un ratto nel Sud America, consumato da un odio crescente verso una sorte che ritiene ingiusta. Un odio che lo isola, lo inaridisce, lo rende ancora più “mostruoso” agli occhi del mondo e, paradossalmente, anche ai suoi stessi occhi, pur senza mai riconoscersi come carnefice. La sua esistenza, priva di amore, felicità o possibilità di costruire qualcosa di buono, si consuma sotto false identità: prima in Argentina, poi in Paraguay, infine all’interno di una famiglia di contadini ungheresi che lui stesso disprezza, arrivando a definirli “zingari”. Nel 1977, ormai vecchio e malato, lo ritroviamo a San Paolo, in un quartiere povero e criminale che detesta profondamente, sopravvivendo più che vivendo.
Attraverso un racconto che si muove su più piani temporali e si concentra sull’analisi psicologica di Mengele, il cineasta costruisce un discorso più ampio su cosa significhi essere un mostro e su chi possa essere definito tale. Il film suggerisce che la mostruosità non coincide necessariamente con la percezione che un individuo ha di sé: Mengele non si considera un assassino, né un carnefice, ma una vittima del sistema comunista e dell’abbandono della Germania stessa, che — a suo dire — lo avrebbe costretto a vivere come un animale. Secondo Mengele, nel suo agire non c’è stato nulla di male, nulla di criminale: non ritiene di meritare un processo, né tantomeno di essere ricordato come un carnefice. È proprio in questa distorsione morale, in questa autoassoluzione patologica, che il film individua uno dei suoi nuclei più inquietanti: la capacità del male di travestirsi da vittimismo, di negare la propria natura, di riscrivere la realtà pur di sopravvivere a sé stesso.
Allo stesso tempo, le parole di Mengele risultano tanto chiare quanto disturbanti quando si domanda perché lui venga definito un mostro mentre altri medici nazisti o soldati che hanno ucciso, torturato, bombardato, possono continuare a vivere normalmente, senza essere processati né etichettati come tali. È un interrogativo che non nasce da un reale bisogno di giustizia, ma da un meccanismo di auto‑difesa: Mengele non mette in discussione il proprio operato, bensì l’ingiustizia — ai suoi occhi — di essere l’unico a pagare un prezzo simbolico. Questa domanda, che nel film emerge con forza, non serve a umanizzarlo, ma a mostrare la profondità della sua deformazione etica: Mengele non comprende la gravità delle sue azioni perché non riconosce l’umanità delle sue vittime. Il suo ragionamento è un cortocircuito morale che rivela l’essenza stessa del totalitarismo: la convinzione che il male compiuto sia non solo giustificabile, ma addirittura necessario.
Ho pensato a Hannah Arendt che, sviluppando l’idea della banalità del Male, ci ha fatto misurare fino a che punto i mostri non siano diversi dal comune mortale. Ora, Konstantin Stanislavski diceva che, quando si interpreta un bastardo, bisogna cercare i suoi lati buoni – e viceversa. Josef Mengele ha la sua visione delle cose. Nella sua testa, non si considera affatto l’incarnazione del Male assoluto. “C’erano tanti altri medici ad Auschwitz, perché dovrei essere io l’emblema del Male?”, si chiede. Ha una risposta a tutto, assicura che i nazisti si preoccupavano del popolo. Ma non bisogna dimenticare che il regime nazista ha costruito i campi di sterminio che hanno fatto milioni di vittime. Volevo entrare nella sua testa e sentire la sua parte di umanità, ciò che non lo distingue dagli altri. Non volevo che ci fosse compassione verso quest’uomo. Non c’è compassione possibile per Mengele. Non bisogna compatire. Poi c’è la celebre frase di Sartre: “L’inferno sono gli altri”. L’inferno non è solo Mengele. Era importante per me mostrare tutte le persone intorno, quelli che lo nascondevano, che erano pagati per nasconderlo o esfiltrarlo quando diventava necessario. Alcuni di loro condividevano questa ideologia nazista, altri ne approfittavano per denaro. Il Male non è solo Mengele, sono anche tutte queste persone… Molte sono rimaste impunite.ù
Cit. Kirill Serebrennikov, il regista
Kirill Serebrennikov, nella scrittura della pellicola, non concentra il proprio sguardo sul racconto d’azione o sulle gesta del protagonista, ma costruisce una narrazione interamente fondata sull’indagine psicologica dell’essere umano. L’obiettivo è chiaro: raccontare Mengele al di fuori delle sue azioni crudeli e brutali, scegliendo di mostrarlo esclusivamente nel suo periodo di vita da latitante e non come medico nazista. Questa scelta, pur rischiosa, permette al film di concentrarsi sulle conseguenze interiori della fuga, sulle fratture emotive e sulla lenta corrosione psicologica di un uomo che porta sulle spalle un passato immenso e inconfessabile. Attraverso questo sguardo ravvicinato, il cineasta indaga gli effetti devastanti di una latitanza quasi obbligata: Mengele diventa un uomo sempre più irascibile, sgradevole, incapace di relazionarsi con il mondo, fino a condurre un’esistenza profondamente solitaria. La sua vita assume i contorni di una prigione vera e propria, anche se la cella non è esterna ma interiore. È un’esistenza segnata da dolore, frustrazione e un rancore crescente verso un mondo che, ai suoi occhi, lo avrebbe tradito.
Da questa analisi psicologica e del suo periodo da latitante emerge con forza la tematica portante del film: chi è davvero il Mostro? Serebrennikov affronta la questione con lucidità, mostrando come la mostruosità non sia mai un concetto monolitico. Il film sottrae a Mengele l’aura del “mostro assoluto” per distribuirla anche su altri personaggi: dalla famiglia ungherese che lo ospita per fini economici invece di darlo in pasto alla giustizia, fino alla stessa famiglia Mengele, che lo protegge e lo giustifica. È un discorso complesso, che suggerisce come il male possa essere diffuso, condiviso, normalizzato, e non sempre incarnato da un’unica figura.
Se questa riflessione è ben sviluppata, il film risulta nel complesso pesante e monotono, non tanto per la regia — valida, capace di mescolare un clima noir drammatico, soprattutto nella prima parte — quanto per la ripetitività drammaturgica. La narrazione si snoda su due archi temporali divergenti (passato e presente) non sempre semplici da seguire, snodandosi tra un montaggio alternato, tra prima e dopo, due linee temporali raccontate con il medesimo stile fotografico dove abbiamo una presenza di un bianco e nero e di una macchina da presa, spesso e volentieri, a mano. Nonostante questo avanti e indietro temporale, il ritmo si appiattisce perché il protagonista non evolve: come nella realtà, Mengele mantiene intatti i suoi credo fino alla fine, e questa immobilità interiore si riflette sulla struttura narrativa.
La scrittura dialogica funziona, ma la sceneggiatura non riesce a costruire una dinamica padre‑figlio davvero incisiva nel presente, che avrebbe potuto rappresentare l’epicentro emotivo del film. Rolf, ben introdotto, viene poi abbandonato, lasciato in superficie, privo di un vero sviluppo interiore. Lo stesso accade per la moglie Martha, presentata e poi dimenticata. È un’occasione mancata: il pubblico avrebbe potuto identificarsi proprio attraverso questi personaggi, trovando un varco emotivo in un racconto altrimenti glaciale.
Le uniche sequenze realmente d’impatto sono quelle a colori, relative al periodo in cui Mengele operava nei campi di concentramento. Mostrate, brevemente, come filmati d’epoca che alternano brutalità e momenti di apparente felicità — soprattutto quando il giovane Mengele è con la donna che ama, da cui ha avuto il piccolo Rolf. Queste scene, che accostano l’orrore alla tenerezza, risultano le più potenti dell’intero film, perché rivelano la contraddizione più disturbante: la capacità del male di convivere con la normalità, con l’amore, con la quotidianità. In un’opera che fatica a emozionare al di là della sua solidità narrativa, queste sequenze rappresentano l’unico vero scossone emotivo. E la scelta di riprendere spesso il protagonista da lontano, con una macchina da presa che lo osserva più che seguirlo, contribuisce a mantenere quello stesso distacco che, pur coerente con l’intento del film, impedisce alla storia di colpire davvero nel profondo.
In conclusione
Il film di Kirill Serebrennikov dedicato alla latitanza di Josef Mengele è un’opera complessa, disturbante e volutamente respingente, che sceglie di non offrire alcun varco emotivo allo spettatore. La regia, rigorosa e spesso glaciale, costruisce un ritratto psicologico che rifiuta ogni forma di empatia e che osserva il protagonista come un corpo estraneo, un uomo divorato dal rancore e dalla propria stessa ideologia. È un approccio coerente e necessario, ma che genera anche una certa monotonia narrativa: l’immobilità interiore di Mengele, fedele fino all’ultimo ai suoi credo, impedisce alla storia di evolvere e appiattisce il ritmo.
Note positive
- Approccio psicologico rigoroso e privo di compiacimenti
- Sequenze a colori di grande impatto emotivo e concettuale
- Interpretazione del protagonista
Note negative
- Ritmo monotono dovuto all’immobilità interiore del protagonista
- Personaggi secondari
L’occhio del cineasta è un progetto libero e indipendente: nessuno ci impone cosa scrivere o come farlo, ma sono i singoli recensori a scegliere cosa e come trattarlo. Crediamo in una critica cinematografica sincera, appassionata e approfondita, lontana da logiche commerciali. Se apprezzi il nostro modo di raccontare il Cinema, aiutaci a far crescere questo spazio: con una piccola donazione mensile od occasionale, in questo modo puoi entrare a far parte della nostra comunità di sostenitori e contribuire concretamente alla qualità dei contenuti che trovi sul sito e sui nostri canali. Sostienici e diventa anche tu parte de L’occhio del cineasta!
| Regia |
|
| Fotografia |
|
| Sceneggiatura |
|
| Colonna sonora e sonoro |
|
| Interpretazione |
|
| Emozione |
|
|
SUMMARY
|
3.4
|